I saggi che compongono questo libro rispondono ad una medesima urgenza: tutti nascono dall’esperienza di una persistenza, da un atteggiamento tanto ostinato e insistente quanto discreto e marginale, che, per quasi dieci anni, mi ha spinto a perseverare sugli stessi concetti, sulle stesse figure, sulle stesse immagini.
Persistere significa “far fermare fino in fondo”, far sì che qualcosa si arresti e sia così costretto a mostrarsi in una sorta di innaturale immobilità. Nel mio caso, la persistenza, questa volontà di persistere, spinta fino alla ripetizione, alla ripresa ossessiva, all’utilizzo di pensieri utilizzati come caratteri mobili da comporre e ricomporre ogni volta in modo diverso, si è rivolta all’immagine, a questa unità di senso che sembra sfuggire da ogni parte: figura, fantasma, sogno, allucinazione, simbolo, icona, mito, ma anche immagine verbale, immagine sonora, immagine mnestica. Si potrebbe forse dire che tutti i saggi qui raccolti testimonino di questa mania per l’immagine, per ciò che si dà a vedere, ma anche a sentire, in e per tutti i sensi, impedendo di proseguire oltre.
Questa ricerca si articola su più fronti, allargando di conseguenza il concetto stesso di immagine, il suo statuto ontologico e la sua portata epocale. I confini disciplinari sembrano saltare: né critica né storia dell’arte, né sole arti visive né soppressione delle specificità di ogni singola immagine. L’immagine si espande oltre i propri limiti stabiliti, dalla scultura alla pittura, dalla fotografia al cinema. Ciò che appare, attraverso questi scritti, sono infatti anche i rapporti che l’immagine instaura, oltre che con la vista, con la memoria, il corpo, la società e il concetto stesso di verità. L’attenzione è così, di volta in volta, portata sulle arti visive e su ciò che supera i loro confini.
L’immagine è sottratta agli angusti muri della vista, per divenire visione di ciò che è ancora ignoto. Ciò che anima la scrittura di questi saggi è il tentativo di testimoniare dell’invisto, di questa sorta di inconscio della visione che sembra apparire e scomparire senza tregua all’interno di quelle che Debord ha giustamente definito le società dello spettacolo integrato e che già Heidegger indicava, nel suo L’epoca dell’immagine del mondo, come quelle società in cui l’immagine del mondo, la Weltbild, non è più una semplice raffigurazione o visione del mondo, ma è il mondo stesso concepito come immagine. Ed è chiaro che in un mondo in cui tutto pare divenire immagine, l’esercizio dello sguardo diviene una prassi, non solo conoscitiva, ma etica. Occorre, dunque, che lo sguardo persista, insista, su ogni singola immagine, isolandola e scrutandola, portandola fino alla soglia della visione. Non più un semplice sguardo sulla realtà dell’immagine, ma una visione che la trascenda e la compia, attingendo alla sua memoria e al suo avvenire.
Ritenere che compito della critica sia farsi visione è forse una delle affermazioni più anacronistiche che si possano ascoltare in questi anni. Anni che si barcamenano tra l’assenza di giudizio e il moralismo buonista del politicamente corretto; tra la violenta e sanguinaria iconoclastia di un mondo arcaico e l’entusiasmo adolescenziale e inconsistente di un altro mondo che perde le proprie giornate nello scorrimento senza fine di un cosmo ridotto a pixel su schermi sempre più portatili, sempre più perennemente accesi e luminosi.
Insistere sul carattere visionario della parola critica significa dare all’arte delle immagini – ben altra cosa dalla semplice produzione o postproduzione di immagini – un valore che va al di là tanto dell’intrattenimento culturale quanto della critica sociale. Significa considerare l’arte delle immagini un’apertura su una dimensione ulteriore dell’umano, senza che questo rinvii necessariamente a una dimensione religiosa; significa aprire il mondo a se stesso e, quindi, alla sua alterità, a ciò che esso contiene di non ancora visibile, ma che è già qui, presente, sotto i nostri occhi. Avere una visione, oggi, non significa indicare un’utopica via di fuga dalla realtà, ma far apparire, attraverso l’immagine e non tramite la sua negazione, una luce nera al centro stesso del flusso luminoso e disincantato dell’iperproduzione spettacolare della postmodernità.
In una società che vorrebbe rendere visibile e sempre disponibile ogni istante dell’esistenza, in una sorta di perpetua rete di selfie e cartoline di un’umanità e di un mondo totalmente esposti, avere una visione significa comprendere che l’immagine conserva un lato oscuro, segreto, un punto cieco che rende colui che la guarda a sua volta cieco, non perfettamente vedente. Ogni visione, infatti, porta con sé un momento di accecamento.
Saper guardare, allora, significa anche saper riconoscere l’istante esatto in cui è necessario chiudere gli occhi, il momento in cui dobbiamo lasciar calare l’oscurità affinché l’immagine diventi immaginazione. Solo in questo modo, in questo processo di autoaccecamento che è una visione, l’immagine si fa creatrice di mondi, assolvendo il proprio compito. E, così facendo, rendendosi opaca nel torbido riflesso della visione, l’immagine si fa pensiero, parola, suono, mondo. Il mondo che era divenuto immagine, ora, grazie all’arte dell’immagine, torna ad essere mondo, in un ciclo senza fine, in un’apertura smisurata del cosmo a se stesso. È di questa dismisura che le “visioni” qui raccolte sperano di aver conservato traccia.

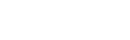


Inserisci un commento