Vivere significa cercare il senso della propria vita; cercare il filo, la necessità, che lega ogni istante a quello successivo, dando all’insieme una coerenza, un disegno in cui sia possibile riconoscersi, avere finalmente un volto. In fondo, l’atto di vivere coincide con il tentativo di scrivere la propria autobiografia o di tracciare il proprio autoritratto. Purtroppo, questa volontà, questa necessità di trovare un significato allo scorrere dei momenti e all’accavallarsi degli eventi si scontra, inesorabilmente, con l’incongruenza del reale e con “l’orrenda fatica” che la tessitura del senso porta con sé. Tracce del passato è il diario di questa fatica, della sua necessità e, nel caso della Woolf, del suo fallimento.
Quando, nell’aprile del 1939, Virginia inizia a stendere i primi abbozzi di queste sue memorie sta cercando di portare a termine la biografia dell’amico scomparso Roger Fry. Fry aveva rivestito un ruolo estremamente importante all’interno di quello che verrà definito il Bloomsbury Group. Critico d’arte di vasta cultura, di diversi anni più anziano della maggior parte degli altri componenti, aveva ben presto assunto un ruolo di guida, non solo nel campo artistico-estetico, ma anche in quello esistenziale dei più giovani intellettuali e artisti londinesi. Roger, oltre ad aver delineato le linee guida di una poetica generazionale, aveva, infatti, avuto una travagliata storia d’amore con Vanessa, sorella di Virginia. La stesura della sua biografia diventa, così, per Virginia, un difficile terreno sul quale si scontrano sentimenti contrastanti. Il libro, come si può evincere dalle pagine dei diari, oscilla tra il tentativo di rendere conto delle opere e della vita di un grande critico e il timore di dover esplicitare (ma come?) l’importanza che Roger aveva avuto nella vita sentimentale della sorella e, probabilmente, anche nella sua (conflitto sentimentale, quello con Vanessa, ripetutosi più volte nel corso degli anni). Come per tutto ciò che ha riguardato il gruppo londinese, la vita si confonde con l’arte, i sentimenti con la scrittura e tutto sembra annodarsi in una matassa esistenziale, spesso dolorosa e apparentemente inestricabile. Da qui la fatica che accompagna Virginia nella stesura del testo consacrato all’amico scomparso. Un testo che sembra, in effetti, più una resa dei conti, per interposta persona, con se stessa e che sembra inevitabilmente spingere la Woolf verso una autobiografia.
Non è, probabilmente, un caso che l’idea di iniziare una raccolta di sue memorie, in vista di un’autobiografia, venga alla Woolf proprio in questo momento e, a giudicare dal suo incipit, proprio a partire da un’osservazione di Vanessa. Sembra, quasi, che l’opera su Fry si ponga come innesco di questa deflagrante necessità di un chiarimento con se stessa e dei suoi rapporti con la famiglia. Ne nasce un insieme di note, non strettamente legate fra loro, che cercano di ricostituire la frammentazione del tempo tra un passato perduto e un presente incoerente, nella speranza di un futuro riconciliato. “Scrivo queste note anche per ritrovare il senso del presente, nell’ombra che il passato getta su questa superficie in frantumi”. Le pagine che compongono questi frammenti autobiografici, però, più che delineare un disegno conciliatorio e consolante, sembrano nella quasi totalità lasciar trasparire un sentimento di allerta sempre maggiore, una tensione che si fa via via più palpabile, quanto più il senso, la direzione, la via d’uscita sembra inesorabilmente svanire, scomparire dietro una selva di fatti ed eventi che non trovano una propria coerenza, che non assurgono “ad opera d’arte, ordinata e compiuta”.
Sembra quasi che la teoria letteraria – la scrittura come strumento di redenzione del passato o come fonte di senso – si disintegri alla prova dei fatti e, ancor più, di quel fatto ineludibile e senza distanza che è la propria esistenza, là dove il presente “ti preme così da vicino che non si riesce a sentire altro”. O, detto altrimenti, occorre che la scrittura si nutra di una certa distanza per assolvere al proprio compito. Se la distanza si assottiglia troppo, allora non c’è che fallimento, disintegrazione. La scrittura esiste solo per interposta persona, solo passando dall’altro, fosse pure un alter ego. Non si dà autobiografia, in realtà. L’autobiografia è destinata, per la sua mancanza di distanza, al fallimento.
Se, in gioventù, la Woolf aveva percepito, quasi come illuminata, la possibilità di una parola (quella poetica) che si faceva reale, più reale della realtà, e aveva quindi individuato nella penna che segue la traccia la quête del senso dell’esistenza, ora, quasi sessantenne, la vita, la propria vita, le si rivela come ciò che non può divenire un’opera d’arte e, di conseguenza, non si destina alla possibilità di un compimento. Per decenni, aveva tentato in ogni modo di far coincidere arte e vita, aveva cercato, in fondo, di vivere nella propria scrittura (a un lettore attento risulterà evidente come tutti i romanzi della Woolf siano autobiografici e, non a caso, solo in essi Virginia crederà di essere in pace e di essersi riconciliata con il proprio passato). Anzi, era stata così terrorizzata dal trovarsi, dal dover trovare se stessa, al di fuori della scrittura che si era imposta una disciplina durissima, di “orrende fatiche”, nella stesura quotidiana di pagine su pagine, correzioni e revisioni, quasi che la vita potesse esaurirsi nelle parole, senza lasciare resti, residui ingombranti. La scrittura era divenuta per lei pharmakos, difesa e antidoto alla vita, al veleno mortale che la vita è per ogni essere vivente.
Della vita, della cruda e insensata esistenza, la scrittrice londinese trattiene solo quelle “scosse”, quei “momenti di essere” che testimoniano di “un altro ordine di realtà” e che, grazie alle sue parole, diventano reali, anche nel mondo ovattato del quotidiano. È, qui, nell’oscillazione tra la paura di esporsi alla nuda e frantumata insensatezza del reale e il rinchiudersi, salva, nella pienezza compatta della parola gravida di senso, che si gioca tutta l’opera di Virginia e, probabilmente, anche tutta la sua vita.
La Woolf, non la sua scrittura, ma lei in carne ed ossa, è il sismografo di queste scosse telluriche dell’esistenza. Lo è, come testimoniano le pagine qui raccolte, dalla più tenera età sino all’approssimarsi dell’intollerabile colpo finale. La sua scrittura è, invece, duttile forma che cerca di mostrare il ritmo di queste scosse, la loro scansione, oscillazione, tracciato, inserendo ogni minimo movimento in una storia, in un tempo in cui ogni cosa trova un senso e una verità. Solo così il mondo, per la Woolf, si riconcilia con se stesso e l’arte, la scrittura, diventano vita, vita più vera della vita.
“Solo esprimendolo in parole posso restituirne la pienezza. Una volta conquistata questa pienezza, il colpo perde il potere di farmi del male. Mi dà anzi grande gioia – forse proprio perché è così che allontano il dolore – ricomporre i frammenti dispersi. [...] Da ciò deriva quella che potrei definire una filosofia. O perlomeno un’idea che mi ha sempre accompagnata. Che sotto l’ovatta si nasconda un disegno; che noi, tutti noi esseri umani, siamo connessi a questo disegno; che il mondo intero sia un’opera d’arte, di cui noi facciamo parte. L’Amleto, o un quartetto di Beethoven, è la verità su questa immensità che chiamiamo mondo. Ma non c’è nessuno Shakespeare, nessun Beethoven, sicuramente e chiaramente nessun Dio; noi siamo le parole; noi siamo la musica; noi siamo le cose stesse”.
“Io sono la mia scrittura”, è questa la frase segreta, il credo absconditus, che accompagna Virginia nello scorrere degli anni. È la speranza di ricomporre ciò che è scisso nel mondo, di ricomporre, seppur attraverso la fatica della scrittura, il senso in frantumi di ogni biografia. “E così sono portata a credere che sia proprio la capacità di ricevere queste scosse a fare di me una scrittrice. Mi azzarderei a motivare questa affermazione con la constatazione che, nel mio caso, ognuna di queste scosse è immediatamente seguita dal desiderio di trovarvi una spiegazione”.
In queste pagine diamantine, Virginia descrive, forse come non mai, la sua poetica, il senso della sua scrittura. E, così, immediatamente, comprendiamo che questo senso, la scrittrice, vorrebbe coincidesse con quello della propria vita, esponendosi, però, in questo modo, al pericolo di irrigidire l’elasticità fluttuante degli eventi nell’armatura della sintassi. Ovviamente, fin troppo sensibile è il sismografo Woolf perché Virginia non percepisca il rischio che molto, forse troppo, vada perduto in questa trascrizione. E, così, la poetica, nell’esercizio autobiografico, regge solo per istanti, per frasi isolate, per immagini fugaci, “disintegrandosi completamente” quando deve toccare il più intimo, il più fragile, il più nascosto, l’inconfessabile. In quegli istanti, forse, Virginia percepisce il proprio limite di scrittrice o, forse, la propria fragilità di donna; o, forse, rivelandosi il primo, emerge ineludibile la seconda, spingendola, attraverso momenti di stasi e sospensione sempre più frequenti, verso una depressione crescente, non certo alleviata da una situazione storica, la seconda Guerra Mondiale, tragicamente distruttrice.
Tracce del passato più che una classica autobiografia è la cronaca del disvelarsi, sul corpo letterario di una donna ormai matura e famosa, di una ferita mai rimarginata, di una frattura scomposta e non ricomponibile. È come se, in realtà, – attraverso il ricordo di una ragazza che si scopre scrittrice e le vicende della sua famiglia, sullo sfondo della società inglese tardo-vittoriana, ormai decadente – si divenisse spettatori della ricostruzione di un lento, ma inesorabile, cammino di avvicinamento a un abisso o a un’immagine finale. Nel passaggio da una pagina all’altra, da una immagine all’altra, non si riesce, però, a comprendere se la figura finale, la figura che dovrebbe rilevare e dissolvere tanto quella della madre quanto quella del padre, come pure quelle dei fratelli e delle sorelle, quella figura che dovrebbe mettere la parola fine, lasciando apparire forse un “io” pacificato con il “noi”, riuscirà a ricomporre la ferita originaria o se sarà solo il prodromo di uno squarcio definitivo, dello squartamento.
Il lettore si trova dinnanzi a una sorta di resa dei conti, rinviata per troppo tempo, quasi rimossa dalla scrittrice, e che ora deve trovare uno sfogo. I suoi protagonisti sono, da una parte, l’origine, la nascita, i legami di sangue, e dall’altra, la morte e la dissoluzione di ogni legame, che cadenzano il ritmo della vita. La Woolf cerca, senza tregua e senza risparmiarsi nulla, di individuare tutte le nascite le morti e le rinascite che accompagnano una vita. Nascere è iniziare a morire, sostiene un vecchio adagio. E la vita intera è una forma di preparazione alla morte, al momento finale, ha a lungo pensato la filosofia. Non lontana da questa saggezza plurimillenaria, per Virginia, il modo per imparare a morire è lasciare che la vita passi attraverso la scrittura.
La scrittura che si configura, così, ai suoi occhi, come il modo per ricomporre il tempo, attraverso la creazione di figure che abbiano un carattere, una coerenza, una storia o, ancor più e detto altrimenti, come il solo modo di vivere la morte. Se dunque nascere è iniziare a morire, allora morire (nella scrittura) è iniziare a vivere. Ed è proprio questo, questo esercizio creativo di figure e immagini, questo tentativo di iniziare a vivere attraverso l’esperienza letteraria della morte, questa iconogenesi ad aver caratterizzato la sua intera esistenza, cioè la sua intera opera letteraria, da Mrs Dalloway a To the Lighthouse, dal suo capolavoro The Waves fino al suo edito postumo Between the Acts. A questa storia, a tale errante passaggio dalla vita alla morte e della morte alla vita, però, occorreva un’immagine finale affinché tutto assumesse un senso saldo, stabile, fermo. Ma quest’immagine, che forse Virginia aveva sperato di trovare proprio in ciò che le era più prossimo, la sua biografia, sfugge, non si dà. La storia non si compie. Non c’è epilogo. Rimane una frase sospesa, troncata, mutilata. Semplicemente, si interrompe – finisce, come tutto finisce, senza una spiegazione, senza una ragione.
“Se qualcosa di buono (e ne dubito) può esservi in queste mutilazioni, è la capacità che hanno di rendere le persone più sensibili. Mi chiedo se avere consapevolezza della precarietà della vita; ricordare cose, persone, perdute per sempre; sentire, a tratti, e in modo quasi insopportabile – come io sentii per papà quando lui non ne aveva alcuna aspettativa – un’appassionata e tremante affinità; mi chiedo se sia un bene essere consapevoli, a tratti, di tutto questo a quindici, sedici, diciassette anni – se, se, se. È stato un bene? Non sarebbe stato meglio (ammesso che abbia un senso usare le parole ‘bene’ e ‘meglio’ quando non esistono giudici, né parametri, possibili) continuare a sentire attorno a sé, come a St Ives, lo scorrere sicuro e incessante della vita domestica?”
Domande senza risposta, questioni che possono restare solo alla forma interrogativa. Forse, solamente nella loro sospensione si apre, per la Woolf, come per ognuno di noi, l’indecidibile possibilità di un senso. Che il senso, alla fine, ci sia dato, non è per nulla certo.

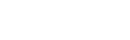
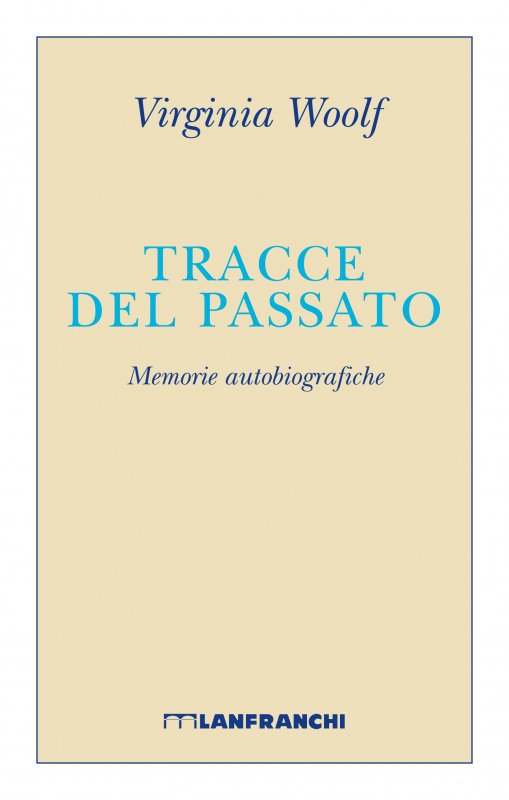

Inserisci un commento